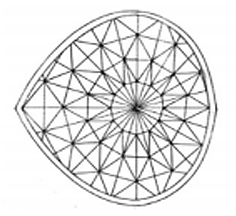Roberto Batisti
questa è la libertà assoluta, il premio afferrato dai catari, dalla confraternita del Libero spirito, dai Lollardi, da Giovanni di Leida, dai Ranters, da Adolf Hitler: la fine del mondo. Questo è il fuoco intorno al quale i dadaisti e i gruppi stranamente fecondi di Debord fecero le loro danze, e che li consumò. Un fuoco, però, che si può sentire anche nelle parole che si lasciarono dietro a causa del rumore che fecero i Sex Pistols.
G. Marcus, Lipstick Traces
Nel suo classico Lipstick Traces (tomo erudito e fazioso, affascinante e insopportabile), il critico Greil Marcus si fa in quattro per inserire il punk in una genealogia sotterranea/sommersa dei movimenti millenaristi e libertari, che per il tramite novecentesco di Dada, lettristi e situazionisti (ai quali sia il facilitatore del punk inglese McLaren, sia quello della scena newyorkese Terry Ork indipendentemente s’ispiravano) risale per li rami ai movimenti ereticali del Medioevo e allo Gnosticismo. Uno sforzo suggestivo e quasi convincente, quello di Marcus, anche se da un lato carica forse di troppo gravosi quarti di nobiltà un movimento la cui forza era proprio il gesto rapido e incendiario che brucia i ponti con il passato; dall’altro disconosce – proprio lui, americano! – l’apporto fondamentale, e cronologicamente prioritario, della scena di New York rispetto a quella britannica.

Lo stesso Hell, Tom Verlaine, Patti Smith, forse non erano particolarmente interessati agli Anabattisti, ma quanto a capacità di teorizzazione esplicita e consapevolezza dei legami con le avanguardie storiche andavano certo molto oltre il teppismo spontaneista di buona parte del punk britannico. Per non parlare del ramo ancora più esoterico e oscuro del movimento newyorkese, quella No Wave fatta praticamente tutta di artisti e intellettuali outsider prestati alla musica (o meglio alla sua distruzione).
Comunque, mettendo in risalto le radici del punk come “Ur-avanguardia politica” (così sintetizza il suo eminente collega Robert Christgau), Marcus ci consente di tornare anche al valore politico del nascondersi/immergersi/trapassare. Anche il clandestino (da clam, l’ennesimo derivato di *ḱel-) cantato da tutti gli anarchici contemporanei è infatti colui che ‘si pone sotto copertura’. La prima ‘copertura’ è, fisicamente, la corazza esteriore, da armadillo – il cuoio, le borchie, le spine del look punk più tipico – con cui il millenarista si prepara per l’imminente apocalisse. C’è però anche un aspetto meno superficiale. Come i catari o i lettristi, anche i freaks e i licantropi storditi che scivolano dentro il club-grotta nel ‘paese dell’alba’ sono una setta clandestina mistica e rivoluzionaria, che si stringe attorno alla promessa di una felicità fuori dal mondo.
faudrait finir comme Richard Hell / disparaître dans la ville
Métro Verlaine, “Richard Hell”
In “Downtown At Dawn”, però, c’è tutta l’ambiguità di questa promessa. È la canzone di un ultratrentenne tossico di lungo corso, re del Lower East Side che non sa più deporre la corona; non di una ragazza tutta energia positiva e colori day-glo, come Poly Styrene. La dropout disco esiste solo come ideale impossibile, di cui i vari templi storici della bohème non sono che approssimazioni imperfette. Anche le altre uscite dal mondo che quella generazione esplorò, come l’eroina (o, da noi, l’ascesi terroristica), seducono con la promessa di un’immersione nelle acque dell’oblio beato, ma mostrano presto il loro lato squallido e fatale. L’ambivalenza del messaggio non mancava di tormentare Hell, che in “Don’t Die” ammette l’irresistibile attrazione dell’abisso per quelle persone (Parker, Lautréamont, Monroe) a cui un’acutezza congenita di sguardo, sorella del talento, fa dolorosamente vedere tutti i limiti e gli inganni della nostra condizione:
There I see the piercing eyes that look through all until they see their back
There where any thought will think about itself and that’s the only fact
There a man has left just death, delerium, and drugs, or feel the lack
Quando descrive quello sguardo penetrante, Hell sta di fatto descrivendo anche il suo – gli occhi del dèmone, dell’insetto paranoide, che dardeggiano pugnali nei cuori, fino a trafiggere sé stessi. Lo sguardo di chi è troppo lucido per non vedere lo scacco che lo attende in fondo al tuffo. Uscire dal mondo, nascondersi al mondo: ma come, dove, se “the world a person lives in / is his brain”? E così “no fate worse than to never leave yourself / and it’s as well the most repulsive pain”.
Note
[1] Non si penserà, beninteso, a un Richard Hell continuatore più o meno consapevole di temi poetici indoeuropei. Che la sua opera musicale e letteraria sopporti questo tipo d’indagine, però, è suggerito anche dall’interesse per il valore euristico dell’etimologia e per gli archetipi mitici (greci e no) espressamente dichiarato in certa sua produzione saggistica recente (vd. Hell 2019/2020).
[2] Proprio la compresenza degli aspetti edonistico e maledetto, salvifico e fatale nei testi di Styrene e Hell li rende più interessanti rispetto a quanti, in altre provincie della civiltà (post-)punk, hanno sfruttato il topos della discesa agl’inferi per rendere, più banalmente ed univocamente, il senso della dannazione sociale o personale. Magari attingendo risultati espressivi d’indubbia potenza, anche se al limite della baracconata wagneriana, come nella “Descent Into the Inferno” di Jim ‘Foetus’ Thirlwell. Sinistri clangori industrial che prefigurano, fra gli altri, il calvario della Downward Spiral di Trent Reznor (che traduce e transmedializza, nella sua meticolosa costruzione sonora, gl’immaginarî visivi di Bosch e H.R. Giger). Ma lontani dalla leggerezza, dall’immediatezza, dall’accessibilità pop del punk ‘77, che diventa un pregio sommo proprio quando non impedisce e anzi consente di veicolare, come nei casi attorno a cui si è qui elucubrato, perturbanti interrogativi esistenzial(ist)i. Meglio semmai la catabasi in blu dei New Order, con tanto di coro di rane (sintetiche) della palude stigia.