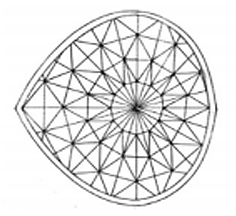Martina Dell’Aira
Rizoma deriva da rizo, dal greco riza e oma, indicando così enfasi e rigonfiamento. La combinazione dei due termini intende significare, non tanto la radice come tale, ma già un principio di crescita, apertura, sviluppo, che si pone nell’ambito di una fuoriuscita dal radicamento nel terreno, dal fondamento (come nella parola tedesca grund: fondamento, ragione). Una radice vera e propria non sussiste. Nella Metafisica tradizionale, o più specificatamente moderna, il sistema arborescente (cfr. Cartesio) comportava una metafora volta a simboleggiare una gerarchia, in cui le radici dell’albero rappresentano il fondamento, ossia la Metafisica propriamente detta. Il tronco, invece, è la metafora della derivazione scientifica dei fenomeni e quindi delle scienze subordinante nella loro specificità e settorialità. Nel quadro del radicamento di questo sistema sono contemplate anche le discipline prossime alla Filosofia: oltre alla Metafisica, la Logica e l’Ontologia. Questo modo di rappresentare la scienza in generale è ciò che viene avversato dai due autori di Mille piani.
Il tentativo è quello di eludere tutta la prospettiva dualistica che si rifà a un retaggio culturale del passato, affinché si delinei un orizzonte non trascendibile, nonché incommensurabile da un punto di vista cognitivo, in forza di una dinamica che muove a posteriori, ovvero dall’esperienza, che vede nell’ambito della corporeità il giogo a cui si intrecciano tutti i meccanismi relativi ai vari settori dell’esistenza. Il corpo costituisce il filo rosso dell’enarrabile, non solo dei fatti ma anche di un’ipotetica narrazione e comprensione di mondi possibili. Dal concetto di rizoma, che segnala per lo più l’assenza di una radice, ossia di un fondamento stabile e necessario, si dipanano altri concetti: di de-territorializzazione e di fuga dallo strato e di rete cognitiva. Il rizoma può essere emblematicamente descritto come il fenomeno che caratterizza le piante graminacee. Si evince quindi una forte propensione al riprodursi in modo espansivo e omnipervasivo, in quanto la gramigna si rigenera mediante semi, radici da nuovi nodi e rizomi. E’ in grado di sopravvivere, attecchire in termini plurimi di diversa natura. Si adatta in vari ambienti e quindi ha una sua diffusa locazione, che si può facilmente riconoscere in qualsivoglia contesto paesaggistico. Fuor di metafora, il rizoma ha la sua centralità nella corporeità.
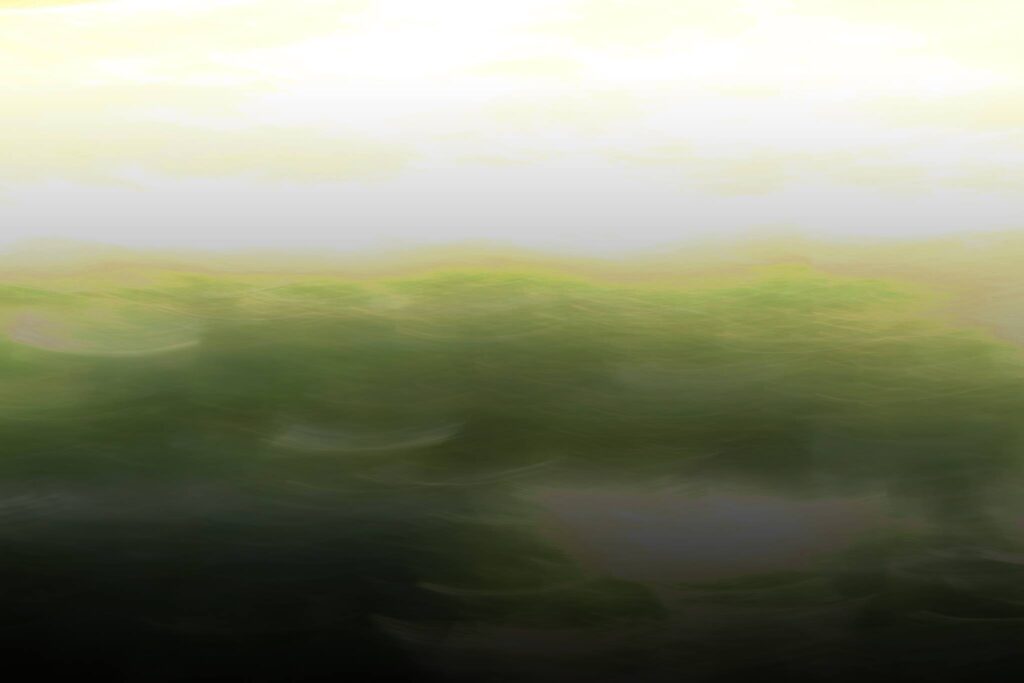
Ma appunto, come la gramigna, trattasi di una corporeità rovesciata rispetto alla visone positivistica fenomenologica in senso stretto (Freud) e strutturalista. La gramigna rappresenta il riscontro di ciò dal quale, intuitivamente, non si può prescindere. Il corpo è sempre stato subordinato all’intenzione, ossia alla volontà o al pensiero, quindi un simulacro dell’esplicazione di un presunto concetto animistico. Questa idea di espansione del rizoma, nonché di diffusione, intende quindi ‘circoscrivere’ la psiche e l’anima a un predicamento del corpo. Il rovesciamento è uno slittamento metaforico, dove l’anima è metafora del corpo e non viceversa, come vuole il senso comune. Si tratta di destrutturare il fenomeno psichico sganciandolo dalle cognizioni di un certo razionalismo, che da sempre vive della storia di un errore filosofico che vuole far recitare al corpo un ruolo comprimario rispetto al pensiero, indice di morte.